
Se ne è andato con la velocità di una folgore, con la velocità con cui annichiliva gli avversari. Il calcio italiano dice addio a Gigi Riva, l’eroe eponimo più autorevole del suo pantheon: lo chiamavano Rombo di Tuono, metteva l’onore sopra ogni cosa. E per raccontarlo davvero ci vorrebbero la poesia del suo amico Fabrizio De Andrè e l’inventiva del suo cantore, Gianni Brera. Perchè se c’è stato in Italia un calciatore che pur essendo mito è riuscito a restare un uomo, quello è stato Giggirriva, come lo chiamavano i suoi «corregionali» sardi. Che lo hanno venerato da quando, nel 1963, arrivò sull’Isola: doveva rimanere al massimo un paio di stagioni, per sfruttarla quale trampolino di lancio, e invece non se n’è più andato, fino all’ultimo giorno della sua vita, oggi. «Perché qui - spiegò a chi gli chiedeva il motivo di una scelta controcorrente - io che in pratica non avevo famiglia, ne ho trovate tante».
Riva rimase in Sardegna, nonostante le grandi squadre lo avessero inseguito e l’allora presidente juventino Boniperti ne avesse fatto quasi una malattia: lo inseguiva con offerte straordinarie, lui continuava a dire no e a segnare in rossoblù. Diventò un simbolo dell’uomo libero e orgoglioso, al punto che persino il latitante Mesina, travestito da frate, come raccontò all’Ansa, lo andava a vedere al vecchio stadio Amsicora, soggiogato dalle giocate e dalla personalità di Riva. Ma al di là del suo orgogliosissimo essere un sardo nato sulle rive del Lago Maggiore, Riva incarnò presto un idolo per tutta Italia. Per la maniera dirompente di segnare (mai un gol d’astuzia, sempre grandi reti di testa o con il suo leggendario sinistro). E per quella generosità che lo portava a dare tanto a tutti, oltre a un paio di devastanti fratture alle gambe alla causa azzurra.
Ha vinto poco, in relazione al moltissimo che valeva: e comunque uno scudetto con il Cagliari, quello storico del 1970, quanti ne vale di quelli conquistati dagli squadroni del Continente? Infatti, con il razzismo tollerato di quegli anni, i tifosi di questi club accoglievano i giocatori rossoblù chiamandoli «pecorai, banditi»: perché, inopinati ospiti, partecipavano finalmente a un banchetto al quale non erano mai stati invitati. Il merito principale di quella squadra rivoluzionaria e vincente, e i suoi compagni di allora gliel’hanno sempre riconosciuto, era di Riva. Nel cui palmares ci sono anche il campionato europeo vinto con la nazionale in finale a Roma nel 1968 (con un suo gol in sospetto fuorigioco, ma allora le moviole non c’erano e nessuno gliel’ha mai rinfacciato), tre classifiche dei cannonieri vinte, il record, tuttora imbattuto, di 35 gol in 42 gare in maglia azzurra. Per non parlare di un secondo e un terzo posto al Pallone d’Oro, quando quella classifica non era specchio dei desideri degli sponsor.
Non era questo il suo calcio, lui che una volta tolti gli scarpini non volle più giocare neanche una partita tra amici, figurarsi tra vecchie glorie... Probabile che gli pesasse quell’aggettivo, di sicuro non amava invecchiare. E preferiva il rumore del suo silenzio, un’altra delle sue caratteristiche «tradita» solo quando da team manager della nazionale doveva difendere i giocatori azzurri. Lo fece alla grande nell’intervallo della finale del Mondiale 2006, spegnendo le intemperanze del ct francese Domenech: un segreto rivelato solo anni dopo da capitan Cannavaro, ma chiaro nel rispetto che tutti i giocatori avevano per lui.
Ora a rendergli omaggio come fosse il loro team manager saranno in tanti, tutti quelli, molti milioni, che per una vita lo hanno amato. Perché ha rappresentato il calcio delle bandiere, quelle che conoscevano solo i colori di una squadra. Perché la sua avventura ha regalato l’anelito profondo del romanzo e del grande cinema (e infatti Pasolini e Zeffirelli lo volevano come attore) e non il ritmo sincopato dei tweet dei calciatori di oggi. E soprattutto perché in un campetto spelacchiato, in uno spazio davanti a una scuola o addirittura per strada, illusi dalla leggerezza dei palloni «Super Santos» e «Super Tele», tutti quanti per un attimo abbiamo sognato di essere dirompenti come lui.
Persone:















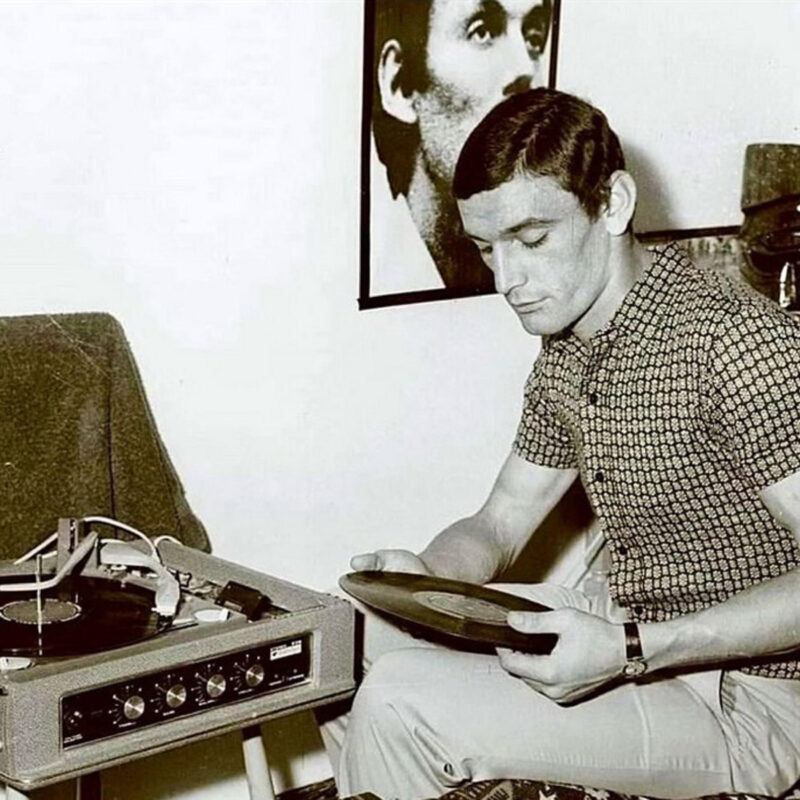


Caricamento commenti
Commenta la notizia