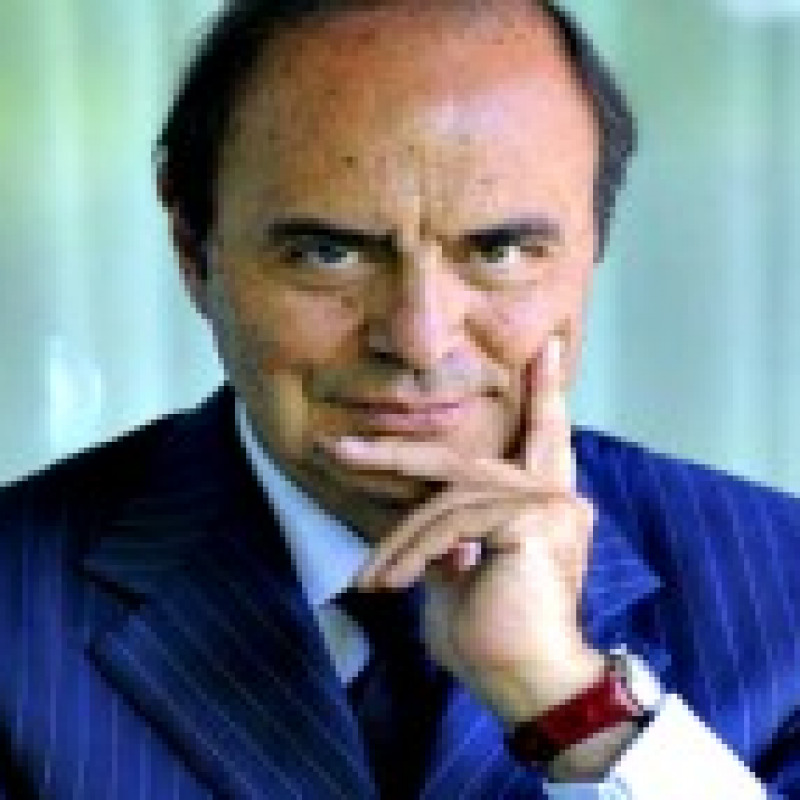
Ciascuno di noi preferirebbe scegliere sulla scheda il deputato che conosce meglio o comunque che stima di più invece di quello imposto dal partito. Ma le preferenze hanno due controindicazioni sulle quali sarebbe bene riflettere. La prima è il costo della candidatura: se debbo farmi largo tra i miei competitori spenderò certamente assai di più rispetto a quanto spenderei se designato dal partito, anche se non necessariamente in una posizione vincente.
La seconda è il pericolo di clientele non sempre pulite. Alle ultime elezioni regionali, solo il 16 per cento dei lombardi ha inserito le preferenze nella scheda elettorale contro il 90 per cento dei calabresi. Abitudini diverse, certo, ma anche un fatale mercato di voti che la storia italiana ci ricorda spesso inquinato dalla criminalità organizzata. È perciò probabile che il no ribadito ieri da Denis Verdini (per conto di Berlusconi) a Maria Elena Boschi (per conto di Renzi) sia destinato a far restare la proposta di legge così com'è su questo punto. Anche perché la battaglia contro le preferenze appartiene alla storia della sinistra italiana proprio in chiave anticlientelare e sarebbe curioso che il Pd cambiasse idea oggi perché Renzi ha ceduto a una richiesta di Berlusconi, imponendogli peraltro il doppio turno. Più difficile sarà per Forza Italia resistere alla richiesta di tutti i partiti (tranne il Pd) di ridurre la soglia d'ammissione del 5 per cento: un'eccezione per la sola Lega è improponibile e occorrerà perciò trovare un equilibrio ragionevole tra una sentenza di morte per quasi tutti i piccoli partiti e la permanenza di un inaccettabile diritto di veto che l'Italia si trascina dietro dai tempi della Prima Repubblica. (A Buckingham Palace ricordano ancora l'improvviso annullamento di una visita di Stato di Francesco Cossiga per uno starnuto del segretario liberale Renato Altissimo…).
Un accordo generale alla fine andrà trovato anche per l'avvio delle riforme costituzionali perché una crisi di governo ed elezioni anticipate sarebbero devastanti per tre ragioni. I mercati volgono al peggio (ieri lo spread è risalito prepotentemente) e ce la farebbero pagare. Si voterebbe con il sistema proporzionale facendo rinascere con certezza un governo di larghe intese. Il presidente della Repubblica si dimetterebbe aprendo una crisi istituzionale spaventosa. Occorre dunque andare avanti e con molta urgenza, visto che il portafoglio di tanta gente continua a essere vuoto e le prospettive dell'occupazione e della crescita continuano a essere pessime. «Ah, per dire certe cose ci vorrebbe un giornale ...», sospirò il direttore del Corriere della Sera Mario Missiroli quando la moglie dell'editore Aldo Crespi gli suggerì negli anni Cinquanta di essere meno clamorosamente cauto nella linea politica. Sarebbe un guaio se Enrico Letta rispondesse «per fare certe cose ci vorrebbe un governo…» alle incalzanti sollecitazioni di Matteo Renzi. Un governo c'è e sta facendo anche del buono.
Ma sta facendo davvero tutto il possibile, con la maggiore urgenza possibile e con tutti gli uomini adatti alla bisogna? Su questo punto Letta, Alfano e Renzi stanno giocando a fare i democristiani (i primi due lo sono stati, il terzo non ha fatto in tempo, ma è cresciuto con i biscotti intinti nel bianco latte). Alfano sollecita un rimpasto pur sapendo di rimetterci (ma il retro pensiero è che solo così assicura la durata del gabinetto), Letta non si pronuncia pur sapendo che la squadra ha qualche pezzo debole, Renzi dice che spetta a Letta pensarci perché non vuole essere contaminato da eventuali, ulteriori inefficienze. La prospettiva è che se il governo Letta (1 o 2 poco importa) non mette il turbo, lo stesso Napolitano chiederà a Renzi di andare a palazzo Chigi prima del passaggio elettorale.






Caricamento commenti
Commenta la notizia